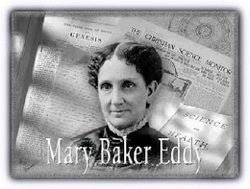 di Marco Focchi Cosa si intende quando si parla di valutazione dei risultati nelle psicoterapie? Può sembrare scontato. Le psicoterapie razionali, a differenza di quelle che Singer e Lalich hanno battezzato psicoterapie folli – cioè senza paradigmi teorici precisi di riferimento, stravaganti nei loro modi d’intervento e discutibili negli obiettivi che perseguono, come viaggi rivelatori nel passato, guarigione cosmica o guarigione della Dea bianca – hanno precisi modelli di riferimento, punti di mira ben riconoscibili, risultati verificabili. La razionalità ci salva dal magma indefinito di un misticismo che collega tutto con tutto, e in cui niente viene mai a capo di esiti tangibili. Siamo sicuri però che la ripartizione razionale/folle sia una buona guida per sceverare, in questo campo, il grano dal loglio? Il confine tra ragione e follia, così saldo agli albori della modernità, concretatosi anche fisicamente con solidi muri di separazione come quelli dei manicomi, non ha più tanto credito nella riflessione contemporanea. Foucault, su questo, ha segnato un punto senza ritorno. Prendiamo tuttavia una nozione di razionalità come quella proposta da Max Weber, basata sulla calcolabilità: è razionale ciò che è calcolabile. Nella sua visione la razionalizzazione costituisce il nerbo delle moderne burocrazie, che si fondano su una gerarchia d’autorità, sull’impersonalità, su precise regole procedurali scritte, su una mobilità verso l’alto dei funzionari mossa dal raggiungimento di risultati, sulla divisione specializzata del lavoro, sull’efficienza. Se questa logica ha trovato piena espressione negli anni Cinquanta nella fabbrica fordista, lo stile Toyota degli anni Ottanta non l’ha certamente rovesciata, piuttosto l’ha perfezionata.
Quando ha cominciato a svilupparsi la ricerca sui risultati delle psicoterapie? Negli anni in cui ha iniziato a farsi sentire la necessità di convincere il mondo medico e accademico – in primo luogo – ma soprattutto le compagnie di assicurazione, della validità e dell’efficacia dei trattamenti forniti dagli psicoterapeuti. L’ampliamento dell’offerta di psicoterapia, l’allargamento del suo pubblico, la necessità di toccare fasce di popolazione meno abbienti, soprattutto negli Stati Uniti – dove i cosi sanitari, anche con la riforma Obama, gravavano interamente sull’individuo – hanno reso necessario coinvolgere agenti sociali come le compagnie di assicurazione per sostenere le spese di una risorsa divenuta sempre più ambita, ma non sempre alla portata di chi poteva farne richiesta. Gli amministratori delle compagnie di assicurazione non parlano il linguaggio elusivo, sofisticato, inafferrabile dell’inconscio, parlano il linguaggio arido dei costi-benefici. Se vogliono investire su un prodotto hanno bisogno di ragionevole certezza, e se questo prodotto è l’inconscio hanno bisogno di sapere che gli effetti dell’inconscio sono calcolabili. C’è una diabolica affinità, un’invincibile attrazione fatale tra il linguaggio dello scientismo contemporaneo e quello delle burocrazie amministrative. La calcolabilità dei risultati, che legittimamente la scienza pone a fondamento del proprio metodo d’indagine, e che ha dato il tono al pensiero della modernità, diventa un mantra quando esce dalla cerchia di pertinenza della scienza e si applica indiscriminatamente, come unica fonte di conoscenza e di certezza, al campo della soggettività e al sociale. L’affinità elettiva tra le burocrazie amministrative e l’ideologia scientista contemporanea, affidandosi a questo mantra, crea uno schema di pensiero a senso unico che s’impone e si amplifica attraverso i mezzi di comunicazione di massa formando un solido binario su cui corrono i mezzi veloci della governamentalità contemporanea. O, potremmo dire, con un’altra metafora, determina una banda d’ascolto sopra e sotto le cui frequenze nulla risulta più udibile. I ricercatori che si sono impegnati a dimostrare la validità del lavoro psicoterapeutico, per avere ascolto hanno dovuto quindi sintonizzarsi su queste frequenze e parlare lo stesso linguaggio delle amministrazioni e dello scientismo. In Italia potremmo trovarci in una situazione analoga se passasse la proposta, presentata tempo fa al Parlamento, di mettere a carico del servizio sanitario nazionale i costi delle psicoterapie. La valutazione dei risultati delle psicoterapie, uno dei cui maggiori promotori è stato Lester Luborsky, ha senso solo se ci fondiamo su parametri di misura e su un concetto di risultato inteso come risultato calcolabile, e se possiamo considerare che il successo di un trattamento s’identifica con il conseguimento di un beneficio definibile empiricamente e oggettivabile. Questo significa che una valutazione dei risultati ha senso se possiamo definire una norma per la guarigione, il benessere, o qualsivoglia obiettivo possiamo porci come punto di mira di una psicoterapia. Ci sono naturalmente varianti postmoderne di questo tipo di ricerca, che tentano di inserire una prospettiva narrativa e una ricerca di significati nella stessa ottica aziendalistico-scientista di quella che vede la psicoterapia semplicemente come rimedio di un malfunzionamento inabilitante. Questo tipo di ricerche si avvale di un linguaggio che traduce in sigle o in termini ipostatizzati, purché modellizzabili, le parole classiche che tutti usiamo: chiamare la psicoterapia una “prassi locale storicamente determinata” non sembra particolarmente illuminante, e chiamare il cliente “agentività” sembra un colpo di stiletto al buon gusto nell’esprimersi, prima ancora che un ostacolo alla trasparenza. Si tratta comunque di un tipo di linguaggio finalizzato a mimare l’efficacia, la governabilità dei processi, attraverso la costruzione di modelli che soddisfino l’apparenza di una razionalità calcolabile. Qualunque sia la prospettiva assunta, qualunque sia – modernista o postmoderno – il paradigma di ricerca clinica fatto proprio, lo scopo – ed è difficile non definirlo retorico – è di convincere l’interlocutore aziendale o accademico che le psicoterapie hanno successo. Si tratta dunque di una ricerca la cui spinta in ultima istanza viene da una logica di mercato, il cui linguaggio è modellato sullo stampo della burocrazia, e il cui obiettivo è offrire ai commessi viaggiatori della salute gli strumenti di una sofistica con cui far breccia in un’opinione formata dall’ideologia scientista e plasmata dai media. Questo vale per la ricerca in psicoterapia, ma anche per quella commissionata a pagata dalle grandi aziende farmaceutiche, come per qualsiasi altra modalità retorica la cui divinità garante sia la frase inappellabile, come il decreto di una divinità à la page con i tempi: “Studi dimostrano che...”. Non c’è naturalmente appello al verdetto “studi dimostrano che...”, giacché basta parametrare adeguatamente i criteri della ricerca per pilotarla a dimostrare qualsiasi pregiudizio o ovvietà, dalle basi organiche della malattia mentale, che se non abbiamo potuto documentare oggi emergeranno con il progresso della ricerca, all’effetto benefico delle emozioni positive sul buon funzionamento dell’organismo, al ruolo dell’ossitocina come fattore causale dell’amore. Non si può dunque entrare in un confronto dialettico con questo tipo di premesse, e bisogna piuttosto decostruirne gli assiomi fondatori, gli aspetti considerati più scontati, talmente ovvii da non richiedere apparentemente nessuna discussione. Non è, per esempio, naturale pensare che se s’intraprende una psicoterapia si voglia avere successo? Non è la riuscita, il successo ciò a cui tutti puntiamo nel momento in cui ci accingiamo a una qualunque azione? Il successo nel senso moderno del termine, tuttavia, non è ciò a cui punta la psicoanalisi. Dobbiamo chiederci però: cosa significa “successo”? Occorre precisare il “senso moderno del termine” perché “successo” fino alla metà del XVII secolo significava “evento” nella sua accezione più generale, e questo evento poteva essere qualificato come favorevole o sfavorevole secondo i casi. Solo nel corso del XVIII secolo il termine “successo” si specializza nel senso di risultato favorevole, di riuscita. Accanto alle trasformazioni lessicali ci sono però influenze più decisive nella definizione del concetto contemporaneo di successo. Le note analisi di Weber sull’etica del capitalismo mostrano come il successo negli affari – e qui inequivocabilmente il successo deve avere il senso di risultato positivo – sia il segno terreno della salvezza eterna nella concezione calvinista della predestinazione. La visione cupa del puritanesimo calvinista, che avendo eletto il lavoro a unica manifestazione di virtù, guarda con occhio torvo ogni abbandono al piacere, allo svago, a espressioni di allegria o di felicità, e questo crea tensione, malinconia, una cappa greve che impedisce qualsivoglia espressione di gioia spontanea, e alla lunga questa camicia di forze psicologica stringe il corpo nella sua morsa facendolo ammalare. A Parigi si vedevano le manifestazioni teatrali dell’isteria, estrinsecazioni di una cultura che non nascondeva il frutto dolce della vita, ma non lo metteva a disposizione di tutti, e certamente le donne erano quelle che più ne pativano la privazione. Negli Stati Uniti il puritanesimo – importato da quanti fuggivano le persecuzioni dell’arcivescovo di Canterbury William Laud e di Carlo I – genera un carico di angoscia e di colpa che si riflette bene nelle atmosfere scure dei romanzi di Nathaniel Hawthorne. Quando la morsa dell’angoscia diventa insopportabile però nulla tiene più, e i figli del puritanesimo si ribellano al Dio corrucciato di Calvino, che ci vuole male e che ci tiene perennemente sul baratro della dannazione. L’opprimente clima in cui l’uomo vive l’apprensione di sentirsi sempre sul filo della riprovazione, subisce allora una torsione. Attraverso il New Thought di Phineas Quimby e di Mary Baker Eddy si rovescia l’idea di un Dio che ci condanna a priori e viene promossa l’idea di un Dio tutto amore, che non vuol altro che il nostro bene. Si creano così le premesse del Positive Thinking, che diventerà la filosofia di base delle Corporations americane a sostegno del Motivating Business, e che si diffonderà poi in tutto il mondo occidentale. La nozione calvinista di successo attraversa indenne il ribaltamento dalla malinconia calvinista all’ottimismo forzato del pensiero positivo, e trova linfa nelle espressioni della nascente filosofia autoctona americana, da Ralph Waldo Emerson, con le sue riflessioni sulla self-reliance, a William James, che nella sua Will to believe dà l’imprimatur accademico al volontarismo ottimistico della riuscita. La nozione calvinista di successo, nell’universo tinto di rosa del pensiero positivo, non divide più il mondo tra i salvati e i dannati, ma tra chi è uno winner e chi è un loser, tra i vincenti e i perdenti. Non si parla più di peccato e di dannazione eterna, ma nei confronti del perdente permane come un’implicita condanna morale, perché il presupposto è che se crediamo fermamente alla possibilità di raggiungere i nostri obiettivi, questi si realizzeranno per una incontrastabile legge d’attrazione tra il pensiero e la realtà. La filosofia del successo ha nel proprio nucleo una morale del successo, e se il calvinismo condannava i gioiosi, gli spensierati, i festosi, perché contravvenivano alla severità accigliata dell’etica fondata sul valore del lavoro, il pensiero positivo condanna il perdente perché è la figura moderna del miscredente, che non ha saputo focalizzarsi con energia costante sui propri obiettivi. Il successo, quando significava evento, fino al XVII secolo, era qualcosa che capitava, nel bene o nel male, ma non era qualcosa con cui non ci si potesse mettere in una relazione di responsabilità morale. Siamo responsabili di molte cose, ma ci sono cose che capitano e basta. Se però il successo diventa soltanto la riuscita, e la riuscita dipende dalla nostra azione, la prospettiva cambia completamente. È a questo punto che il successo e il fallimento possono rientrare nel campo del calcolabile. La razionalizzazione del vago misticismo che fa da sfondo al pensiero positivo non parla più di volontà, di legge dell’attrazione, di credere ai propri obiettivi. Parla, più sobriamente, di calcolo. Presentato così il tema del successo perde l’aura mistica che lo sostiene. Il fallimento non deriva dal fatto che non abbiamo saputo credere fino in fondo ai nostri obiettivi, ma da un errore di calcolo. Negligenza del perdente. Se la psicoanalisi, nelle sue espressioni più autentiche, rifiuta il tema del successo, della verifica dei risultati, dell’empirismo positivista ammorbidito nella mistica del benessere, è perché, come già sapeva Freud, si tratta di un mestiere impossibile, che mette a confronto con le antinomie del desiderio più che con le aspirazioni lineari a un benessere che si pretenderebbe non ambivalente. Lo aveva detto anche Musil una volta: mettete un uomo di fronte alla possibile realizzazione immediata di tutti quelli che ha sempre dichiarato essere i suoi desideri e lo vedrete fuggire a gambe levate. È il motivo per cui Lacan ha definito il ratage, far cilecca, come l’oggetto della psicoanalisi. Non il successo, non una riuscita calcolabile e quantificabile, ma il ratage come tocco dell’impossibile. Contro l’idea utopica di un benessere definito dall’OMS come una pienezza a tutto tondo, la psicoanalisi porta il soggetto a confrontarsi con l’impossibile. È un reale a limitare le illusioni che fanno sentire impotenti e frustrati perché non le si raggiunge. Sano è misurarsi con il limite, non lanciarsi verso la chimera alimentata dall’ottimismo onnipotente imposto dal principio di prestazione, o verso gli obiettivi normativi del suo complice segreto: l’empirismo positivista, che ritiene di poter porre il soggetto sotto l’imperativo di un calcolo onnipotente. Entrambe queste forme di onnipotenza, l’ottimismo incondizionato della legge d’attrazione e il calcolo razionalista impropriamente applicato, producono solo frustrazione di ritorno. Nella psicoanalisi, la più radicale esperienza del desiderio umano, sappiamo bene che il soggetto si destreggia tra le sue antinomie, e che proprio questo, facendogli toccare un bordo in cui il linguaggio inscrive il godimento pulsionale, costituisce il sale – a volte troppo forte, ma proprio per questo autentico – della vita nella sua inestricabile e irrinunciabile complessità.
2 Comments
silvia bermudez
3/3/2014 05:25:59 pm
"por eso que Lacan ha llamado el ratage, fallo de encendido, como el objeto del psicoanálisis. No el éxito, no un éxito calculables y medibles, pero el ratage tacto como imposible. Contra la idea utópica de un bienestar definida por la OMS como una plenitud en la ronda, el psicoanálisis lleva al sujeto a hacer frente a lo imposible."no hay promesa de exito ni de felicidad,sino saber hacer cada uno con sus embrollos.Interesante,Silvia Bermudez Bs As
Reply
marco focchi
4/3/2014 01:03:54 am
Grazie Silvia delle tue riflessioni. In effetti sono argomenti che mettono fuori gioco i tentativi fatti fin qui di sviluppare una possibile valutazione in campo psicoanalitico, dove la sola valutazione possibile è in realtà quella che avviene attraverso la passe. Un saluto
Reply
Leave a Reply. |
Marco Focchi riceve in
viale Gran Sasso 28 20131 Milano. Tel. 022665651. Possibilità di colloqui in inglese, francese, spagnolo Archivi
Giugno 2024
Categorie |
 Feed RSS
Feed RSS
