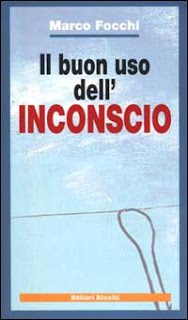 di Marco Focchi Fino a un po’ di tempo fa sembrava chiaro cosa fosse uno psicoanalista: era uno che la sapeva abbastanza lunga da trapassarti da parte a parte con lo sguardo quando la lingua scivolava su un lapsus; ti faceva così sentire tutto il peso di quel che avevi detto senza volerlo dire. Le cose oggi sono cambiate, forse anche per via della grande varietà di strategie terapeutiche man mano messe a punto. Probabilmente agli psicoanalisti si attribuisce ancora la virtù di saperla lunga, ma quel che di più importante hanno acquisito è che la vita non si esaurisce nei simboli, e che ogni trattamento incontra il reale su cui s’inceppano le relazioni: non tutto può passare attraverso l’interpretazione. Nessuno pensa più, come ai tempi della terapia catartica, che sia sufficiente svelare il senso dei sintomi, né che vi siano automatismi toccando i quali si produce immancabilmente il cambiamento atteso. Quando entrano in gioco le relazioni tra il soggetto e l’Altro non possiamo ragionare in termini di connessione necessaria: c’è un margine di contingenza dove qualcosa può essere ma può anche non essere, e che dipende, in ultima istanza, da una decisione soggettiva. Certo quando affiora un disturbo è anche possibile risalire a ciò che l’ha generato. Un disturbo, un sintomo, una manifestazione patologica sono la risposta a un problema che prende forma entro determinate condizioni. Queste sono date da una situazione oggettiva di vita: non è lo stesso nascere in una famiglia dove i genitori si amano o si detestano, che hanno desiderato il bambino o l’hanno accolto come un impiccio, e così via. Non basta però far discendere l’etiologia in modo lineare da queste condizioni: essa va pensata in modo da includere un consenso soggettivo, per quanto inconscio: il bambino infatti comincia subito a rispondere in modo peculiare alle sollecitazioni da cui è investito. Il tipo di relazioni che così si creano formano la matrice di quello che il soggetto si troverà a vivere da adulto. I problemi però vanno risolti nella loro attualità, e il disagio con cui si presentano i pazienti di oggi assume forme diverse da quelle di un tempo. In questo libro ho cercato quindi di svolgere i quesiti clinici che i mutamenti della vita contemporanea impongono alla psicoanalisi di affrontare con urgenza.
Il pensiero psicoanalitico ha prodotto tutti gli strumenti necessari per sviluppare una clinica in grado di trattare le nuove forme del disagio psichico. Si è però diffusa l’idea di una disciplina culturalmente raffinata, concettualmente ricca, ma piuttosto lenta nella sua efficacia, e i cui risultati non starebbero al pari con le attese. Vengono così preferiti orientamenti diversi, che spesso si innestano sul filone delle neuroscienze, quali rappresentanti per antonomasia di soluzioni rapide e di una capacità d’intervento pratico pronta e mirata. La psicoanalisi viene così tratteggiata come una vecchia signora viennese che si prende il lusso di dilungarsi in chiacchiere, certo sì preziose, ma anche un po’ prolisse, sorseggiando il thé del pomeriggio, mentre le nuove tendenze appaiono come snelle e dinamiche fanciulle americane con i muscoli scattanti di palestra. A questa immagine di desuetudine, bisogna purtroppo ammetterlo, contribuisce a volte la scarsa elasticità di un buon numero di psicoanalisti, quando si arroccano ad aspetti rituali della loro pratica come se ne fossero l’insostituibile quintessenza. Ci troviamo così di fronte al paradosso di una disciplina matura, fornita di tutti gli elementi concettuali indispensabili per orientare una cura incentrata sulla soggettività, che viene messa però in cattiva luce da un confronto inappropriato. Anche se è senz’altro importante una verifica interdisciplinare tra i campi, non penso infatti che sul piano clinico si possa istituire un paragone tra la psicoanalisi e le neuroscienze, perché si tratta di prassi formalmente diverse. Le neuroscienze studiano un oggetto, che è il cervello, con i suoi circuiti neuronali e le molteplici versioni operative della mente che se ne possono desumere. La psicoanalisi invece non parte dall’ipotesi di una psiche oggettivata, ma dalla relazione del soggetto con l’Altro. Questa è fatta di storia personale, ed è tenuta insieme dal legame d’amore ancorato al reale della sessualità. Il natura di questo legame trova espressione nel concetto psicoanalitico di traslazione. Sulla base di un eros in forma di traslazione si fondano anche tutte le psicoterapie orientate dalla psicoanalisi: nessuno potrebbe infatti sottovalutare l’incidenza della traslazione, cioè un legame dissimmetrico che mette in gioco il desiderio, in qualsiasi genere di trattamento imperniato sulla relazione tra due o più persone. Qualunque siano i criteri teorici o tecnici su cui le psicoterapie fondano i propri interventi, nessun discorso funziona fuori dal legame di traslazione. La modernità insuperata della psicoanalisi sta anche in questo: prima ancora che la medicina si interrogasse sull’effetto placebo cercando di valutarlo negli esperimenti a doppio cieco,[1] la traslazione aveva già la forza teorica di un concetto mentre la suggestione era un quesito senza risposta. La traslazione è il motore dell’efficacia di ogni trattamento perché pone il problema chiave della funzione irriducibile che la credenza ha in qualsiasi relazione. Il positivismo considerava che la credenza avrebbe dovuto venire soppiantata dal sapere perché la interpretava semplicemente come superstizione, come sopravvivenza religiosa. La sociologia contemporanea mostra che la credenza nella parola dell’Altro, punto cruciale nella formazione dei gruppi umani,[2] è un elemento insuperabile. Non c’è garanzia ultima della parola: lo mostra la promessa nella relazione d’amore, esempio eminente di enunciato esecutivo alla Austin: nessuno ha il titolo d’amante prima di proferire il fatidico: “ti amo”. Ma cosa è in grado di autentificare un simile enunciato? La fiducia, la scommessa, o la certezza sopperiscono all’impossibilità di formalizzare l’Altro come Uno, coerente, esaustivo, mallevadore di verità. L’Altro è il partner che ci sta accanto quotidianamente, quello con cui, giorno dopo giorno, si svolge il gioco della vita: prima sono i genitori, poi i maestri, i compagni, gli amici, gli amanti, le concubine, le mogli e i mariti, i colleghi, le autorità, i soccorritori e i seccatori, i donatori e i sottrattori, gli ammiratori e i detrattori. L’Altro, in ultima istanza, è fatto di incontri, di momenti unici che diventano simboli e che preinquadrano quel che verrà dopo in determinati profili, alimentando le nostre aspettative positive o negative. L’inconscio è l’insieme di queste tracce dell’Altro, di questi elementi significanti, e la ragione per cui l’infanzia è fondamentale è che i primi incontri ci plasmano con forza maggiore. L’Altro però è fatto di tanti pezzi significanti disparati, e l’inconscio, che li raccoglie, non è un insieme coerente. E’ quello che potremmo chiamare una molteplicità senza Uno, una molteplicità disunificata. Si potrebbe supporre che la disunificazione dell’Altro, la pluralità delle forme simboliche nelle loro manifestazioni storiche e culturali conduca al relativismo. Non è così: un reale ritorna come invariante in tutte le diverse espressioni simboliche cui gli uomini hanno dato vita in tutti i tempi e in tutti i luoghi. Esso riguarda l’impossibilità di formalizzare simbolicamente il sesso nel pensiero. L’universalismo della psicoanalisi si fonda su questo postulato: la rigogliosa fioritura di mitologie disparate nei popoli converge sull’inesprimibile della differenza sessuale. Ne deriva che l’Altro, per quanto fatto di elementi significanti, non è completamente riducibile al simbolico. Non tutto gira sui binari prefigurati dal simbolico perché ci sono le sorprese del reale, e il compito analitico non può limitarsi alle interpretazioni e alle ricostruzioni storiche. C’è un’attualità della relazione il cui filo non passa nelle trame del senso e che non si limita a ripetere le tracce del passato: la traslazione non può essere compresa soltanto in base alla ripetizione. Nella vita non si incontrano esclusivamente riedizioni di figure ancestrali. Le relazioni attuali, e in modo elettivo quella analitica, sono in grado di modificare le certezze cristallizzatesi nella storia soggettiva. Lo mostra brillantemente il bel caso di uno psicoanalista americano che ho commentato nel capitolo sulla funzione clinica della certezza. Non c’è guarigione, e vedremo come questo termine vada chiarito, che non tragga origine dalla decostruzione di un convincimento al cuore del soggetto. Non si tratta dell’illuminazione improvvisa, come nei film di Hitchcock, o dell’immaginaria riparazione di un danno subìto. L’apertura sul nuovo viene dal disancoramento di una certezza a cui è abbarbicata la ripetizione nevrotica. Lo vedremo concretamente attraverso alcuni casi. In questa prospettiva la psicoanalisi si presenta come una pratica per intervenire in tutte le situazioni di disagio dove le difficoltà nascono da problemi di relazione. Non ci sono solo le situazioni gravi di nevrosi, di psicosi, di attacchi di panico: ci sono per esempio le sindromi ombra, disturbi del carattere meno appariscenti e rivelatori di una vulnerabilità che sarebbe davvero forzato attribuire, come a volte si fa, a cause genetiche. Vanno da semplici timidezze a eccessiva mania di precisione, iperattività umorale, deficit dell’attenzione. Quest’ultimo è un disturbo che ho potuto studiare su una casistica abbastanza estesa, dato che la mia esperienza, oltre che nel lavoro privato, si è formata nel contesto scolastico, da cui proviene parte del materiale clinico presentato nel libro. Credo sia necessario sfatare il mito che privilegia l’esercizio della psicoanalisi nella pratica privata, per metterne alla prova gli strumenti nei settori pubblici che rischiano altrimenti di infilarsi nel vicolo cieco di un tecnicismo meramente gestionale. Vedremo allora che la vecchia signora viennese sembra vecchia solo per via dei suoi abiti eleganti un po’ desueti, che sono in fondo una ricercatezza, anche se niente affatto irrinunciabile. Per chi lavora nel settore pubblico purtroppo oggi è meno sentita l’esigenza di un’analisi personale come base della formazione. Facendo supervisione nella specializzazione di Psicologia Clinica ho visto a volte gli studenti più preparati, ma privi di formazione personale, smarrirsi nei labirinti della controtraslazione. E’ noto infatti da sempre che le cose che non si imparano sui libri si scoprono solo nella propria analisi. Qualsiasi tirocinio clinico d’altra parte mette a contatto diretto con una ricca varietà possibile di psicopatologie, facendo toccare con mano le implicazioni della domanda di aiuto. Cosa offre di più l’esperienza d’analisi? Offre la possibilità di quel che vorrei chiamare un buon uso dell’inconscio. Sartre ha detto una verità incontestabile affermando che l’enfer c’est les autres. Ogni tormento interiore viene dai nostri simili. O almeno viene dal modo in cui inquadriamo i nostri simili nelle figure dell’Altro che abbiamo simbolizzato. La cosa vale a maggior ragione quando si tratta di partner dell’altro sesso: nell’amore ci si può fare tutto il bene e tutto il male. Anche se la pulsione riesce sempre a soddisfarsi, e sia nel piacere sia nella sofferenza vi è una forma di appagamento, il sintomo nevrotico è tuttavia un un modo poco vantaggioso di ricavare godimento. L’inconscio è un dispositivo simbolico che serve ad attingere un godimento reale. Siccome non è come un frutto sull’albero, che si afferra semplicemente allungando le mani, il godimento può essere ottenuto solo passando attraverso l’Altro, con tutte le complicazioni simboliche che questo comporta. Non sempre con le persone è facile capirsi, è un percorso fatto di equivoci e trabocchetti: si dice una cosa e il partner ne capisce un’altra; si cerca di precisare quel che si intendeva e generalmente si riesce a peggiorare la situazione. Tante volte è come una sabbia mobile in cui più ci si agita per far chiarezza più si sprofonda. I Cinici, intendo dire i filosofi, avevano pensato di risparmiarsi tutti questi fastidi evitando il passaggio per l’Altro e provvedendo da sé a soddisfarsi. Ma non è una buona soluzione. Il buon uso dell’inconscio è una cosa diversa: è quello che passa per l’Altro dopo aver consumato gli idoli dell’Uno. Se l’Altro si fa avanti sempre sotto il marchio originario di una risposta insuperabile, un rifiuto subìto, un inganno, un’ingiustizia, una seduzione, un lampo che ha impresso la negativa da cui traiamo con poche variazioni le immagini della nostra vita, allora nulla di nuovo può valere se non in quell’Uno di cui di volta in volta si modificano solo leggermente i tratti. L’esperienza psicoanalitica consiste nella disaggregazione dell’Uno. Naturalmente la ripetizione non è mai completamente superata, ma se ne possono allargare le maglie abbastanza da far posto a modalità di relazione con gli altri che non vadano sotto il segno di un’aspettativa pregiudiziale, e questo fa sì che gli altri siano un po’ meno enfer e un po’ più fonte di sorprese, anche se non necessariamente le paradis. Credo che un modo più preciso per definire il risultato di un’esperienza d’analisi, più che parlare di guarigione sia riferirsi a un buon uso dell’inconscio. Innanzi tutto guarigione indica uno stato che si contrappone a quello di malattia. E’ difficile però considerare il disagio psichico come uno stato, e altrettanto si può dire per il benessere. Stiamo bene finché siamo in grado di fruire positivamente delle nostre risorse, e stiamo male quando il nettare della vita si trasforma in un amaro veleno. In entrambi i casi si tratta di situazioni dinamiche e per star bene non si può star fermi, occorre contribuire a che le cose vadano bene. Il soggetto non è mai completamente passivo. Il tracollo psichico, il trauma, l’evento scatenante che stanno all’origine di certe insorgenze nevrotiche improvvise non sono in realtà la causa ma solo l’occasione che rivela la struttura soggiacente. L’ostacolo reale è all’origine, e non è affatto genetico: è la mancanza d’essere che tocca ogni parlante, e rispetto alla quale ciascuno cerca delle vie possibili di compensazione. Ma non c’è superamento della mancanza o eliminazione dell’ostacolo. La vita è vivibile finché la compensazione funziona, altrimenti tutto si rivolta contro, ed è l’enfer. Con il buon uso dell’inconscio dobbiamo intendere proprio questo: trasformare l’ostacolo in risorsa cercando di stare con i nostri simili non senza passioni, ma senza abbracciare il destino di personaggi alla Balzac, la cui vocazione esclusiva sia farsi distruggere dalle proprie passioni. [1]W. A. Brown, “L’effetto placebo“, in Le scienze, n° 355, mar. 1998. [2]Cfr. M. Gilbert, “Credenze collettive e mutamento scientifico“, in Fenomenologia e società, n° 1, 1998
1 Comment
Bohuslava Shevchenko
28/11/2023 04:37:04 pm
Mi sento così felice e mi piace condividere la mia storia, mi chiamo Bohuslava Shevchenko, sono una donna felicemente sposata con 3 bellissimi bambini e un marito amorevole, voglio ringraziare il signor Nosa Ugo che mi ha lanciato un incantesimo d'amore che mi ha fatto mio marito è tornato, per me ha funzionato ed è per questo che condivido questa storia, sono il tipo che non ha mai creduto al lancio degli incantesimi. Non avevo altra scelta che provarlo. Ho fatto tutto quello che mi è stato chiesto di fare e tutto ha funzionato bene, il signor Nosa Ugo mi ha aiutato a ravvivare la mia relazione, dovevo condividerlo qui per chiunque voglia un incantesimo d'amore o qualsiasi tipo di incantesimo come, se vuoi un incantesimo di buona fortuna, incantesimo di protezione spirituale, incantesimo portatore, incantesimo vincolante, puoi contattarlo tramite e-mail
Reply
Leave a Reply. |
Marco Focchi riceve in
viale Gran Sasso 28 20131 Milano. Tel. 022665651. Possibilità di colloqui in inglese, francese, spagnolo Archivi
Giugno 2024
Categorie |
 Feed RSS
Feed RSS
