|
Conferenza tenuta via zoom il 16 dicembre 2020 per la comunità milanese della Scuola lacaniana di psicoanalisi. Marco Focchi Se ci domandiamo a che punto siamo con la psicoanalisi oggi, è perché ci stiamo ponendo un problema molto diverso da quello che si formulava nel titolo del convegno tenuto a Milano nel giugno del 1992. Allora non c’era ancora la SLP (Scuola Lacaniana di Psicoanalisi), e il convegno si teneva sotto la sigla del GISEP, il gruppo di studio che aveva il compito di preparare il terreno per la costituzione della SLP. Il titolo del convegno era: L’identità freudiana della psicoanalisi e l’insegnamento di Jacques Lacan (1). Nel ’92 il problema era in effetti riconoscere e affermare la filiazione freudiana della nostra pratica, trovare il filo di continuità che la rendeva riconoscibile come portatrice del marchio del fondatore. Era chiaro allora che il nome di Freud era un Nome-del-Padre, che era una parvenza, e questo era reso esplicito anche nell’intervento conclusivo di Jacques-Alain Miller. Quelli erano tuttavia anche gli anni in cui ci ripetevamo la frase di Lacan che del Nome-del-Padre possiamo fare a meno a condizione di farne uso. Il riferimento all’identità freudiana andava dunque in questo senso: far uso, dove questo significa che la parvenza è quel che utilizziamo per puntare al reale. L’identità freudiana non veniva definita a partire da un’insegna, ma dal procedimento: il paziente parla della modalità dell’associazione libera e l’analista risponde nella modalità dell’interpretazione. Una discriminante fondamentale è poi che tale dialogo sia sostenuto dalla traslazione piuttosto che dalla suggestione. Questo implica che lo scambio verbale non si riduca agli effetti retorici da cui discende il convincimento della verità, ma che si verifichino dei trasferimenti di godimento, e che il lavoro analitico incida in questo senso sul reale.
Accanto al procedimento, il carattere freudiano della psicoanalisi si riconosce nelle coordinate della clinica. Miller le sintetizza in quattro assi: il narcisismo, rifiutato dalla psicoanalisi dell’io, la libido, il fallo, la coppia Eros/Thanatos, cioè la pulsione di morte, la cui idea era stata respinta dalla maggior parte degli allievi di Freud. L’accento messo sul procedimento per riconoscere l’identità freudiana tende a far valere più quel che si fa che non quel che si dice, a mettere in luce più le operazioni della psicoanalisi che non le sue elucubrazioni. È, direi, un criterio di sobrietà. Credo sia giunto il momento di domandarsi se oggi per noi il problema sia ancora di riconoscere l’identità della psicoanalisi, e in particolare l’identità freudiana, stante che due anni dopo questo convegno, per esempio, abbiamo scelto di battezzare come lacaniana la Scuola che stavamo facendo nascere. C’è stato infatti un momento in cui, ricordo, Miller era molto reticente sul fatto di denominare lacaniane le istituzioni e strutture che man mano nascevano nel Campo freudiano, e in fondo questa riserva è senz’altro strettamente collegata con l’idea che il lacanismo sia il naturale proseguimento dell’identità freudiana della psicoanalisi, anzi, il suo autentico proseguimento dopo le diverse deviazioni e dottrine che hanno trovato sede nell’IPA. È interessante ricordare che la Scuola lacaniana di psicoanalisi italiana fu la prima ad adottare denominazione di “lacaniana” nel Campo freudiano, tanto che i nostri colleghi spagnoli, che poco tempo dopo hanno a loro volta battezzato la loro Scuola Escuela lacaniana, lo hanno fatto dietro il nostro impulso e, bisogna dire, un po’ risentiti di non essere stati consultati prima. In fondo possiamo dire che la rivendicazione di una identità freudiana prende il seguito dalla polemica con l’IPA su chi sia il vero erede di Freud. Si tratta di un tema degli anni Cinquanta. Oggi questa rivendicazione, e di conseguenza questa polemica, non hanno più luogo d’essere. Anche sul piano clinico, ci siamo abituati a riconoscere una pratica freudiana, incentrata intorno al padre, e una pratica che, all’interno del freudismo, si specifica come lacaniana, e che vede nel declino del Nome-del-Padre una via per il trattamento del godimento. È una modalità operativa che si aggiunge a, e si diversifica da quell’amore per la verità che si mostra con forza nel testo freudiano. Consideriamo d’altra parte quel che Miller tiene come filo rosso per definire la continuità rispetto all’ abbrivio freudiano, cioè il procedimento. Dobbiamo dire che , per molti versi, anche il nostro procedimento è cambiato. Non si tratta solo del quadro all’interno del quale il procedimento si svolge. Le differenze nel quadro saltano agli occhi. Freud vedeva i propri pazienti per cinque giorni alla settimana in sedute di un’ora. Chi di noi vede oggi i propri pazienti tutti i giorni? Dal tempo di Freud si è prodotta man mano una rarefazione degli incontri. Quando io ho iniziato le mie esperienze di psicoanalisi, negli anni Settanta, un ritmo di due o tre sedute alla settimana era considerato lo standard. In un dibattito svoltosi all’IPA degli anni Ottanta come discriminante, per distinguere la psicoanalisi dalla psicoterapia si poneva il numero di sedute: fino a tre settimanali era considerata psicoanalisi, due psicoterapia, una seduta alla settimana era ritenuta semplicemente un sostegno. All’IPA non erano riusciti a trovare altro che questo criterio esterno, perché nel proprio seno istituzionale hanno accolto l’eclettismo più eterogeneo, e i principi che stanno alla base della cura sono estremamente diversificati in base alla corrente in cui ogni analista si riconosce. L’identificazione della psicoanalisi non poteva essere fatta dunque che attraverso lo standard: numero di sedute, loro durata, la loro burocratica regolarità. A questo proposito credo sia interessante riferirsi un concetto proposto da John Searle negli anni Sessanta introducendo una differenza tra quelle che definisce regole regolative e regole costitutive (2). Per illustrare la differenza tra standard e principi nella pratica psicoanalitica avevo utilizzato questo riferimento in un mio testo al tempo in cui facevo parte del Comitato d’azione per il Congresso AMP del 2004 a Commandatuba (3). Graciela Brodsky l’aveva ripreso in un suo successivo intervento (4). La differenza tra i due livelli di regole consiste nel fatto che le regole regolative ordinano dall’esterno una situazione preesistente. Per esempio il codice della strada disciplina la circolazione, ma questa esiste indipendentemente dal modo in cui viene normata. Il galateo offre indicazioni per i rapporti tra le persone, ma purtroppo si vede che se ne può fare a meno, anche se questo implica un peggioramento nella qualità dei rapporti. Le regole costitutive sono invece quelle che creano una situazione: per esempio che l’alfiere muova in diagonale, la regina in tutte le direzioni, il cavallo di tre caselle avanti e una a lato, dà luogo al gioco stesso degli scacchi. Così come nel gioco del calcio il fatto di toccare la palla con la mano implica un fallo (salvo essere Maradona con la mano de Dios) e questo forma parte essenziale del gioco. Vediamo allora che le regole sulla durata e sulla frequenza delle sedute, sul comportamento o l’abbigliamento che l’analista deve tenere, queste regole proposte dall’IPA sono regole regolative, sono esterne, non toccano la logica intrinseca della operazione psicoanalitica. Le regole che interessano a noi sono invece quelle costitutive, quelle tolte le quali la pratica non esisterebbe più. Ora è interessante vedere come le regole costitutive abbiano radici in quelli che Ludwig Wittgenstein chiamava i giochi linguistici, cioè l’insieme di operazioni all’interno delle quali prende senso quel che si dice e quel che si fa. Quando smette di considerare il linguaggio come lo specchio del mondo, come catalogo di nomi considerati etichette per indicare le cose, nella seconda fase della sua riflessione Wittgenstein comincia a vedere i giochi linguistici come costitutivi delle forme di vita. Non è difficile secondo me vedere come la psicoanalisi sia, in un certo senso, un gioco linguistico di questo tipo. Lo dimostra un esempio molto semplice: l’enunciato di un’interpretazione ha valore solo nell’ambito della relazione di traslazione. Se uscito dalla seduta l’analizzante riferisce a un amico la stessa frase che l’analista ha pronunciato in seduta e che lo ha straordinariamente colpito, questa non produce sull’amico nessun effetto, perché non è dentro quel tipo di gioco che si è man mano determinato tra l’analizzante e il suo psicoanalista. Wittgenstein esprimeva questa idea in modo particolarmente icastico: se un leone sapesse parlare – diceva – non lo capiremmo, perché non condivide le nostre stesse forme di vita. Vale la pena di considerare il modo in cui Searle formula la differenza tra regole regolative e regole costitutive. Una regola regolativa ha la forma “fai X”, cioè un comando, un’espressione che riconduce al discorso del padrone, oppure: “se X, allora Y”, cioè un’implicazione, per esempio: se imbocchi un senso vietato allora prendi una multa. Questa seconda formula è declinabile anche nel senso del discorso scientifico, per esempio: se portiamo l’acqua a cento gradi questa bolle. Le regole costitutive hanno invece una forma diversa, ovvero: questo X vale Y nel contesto C. Vediamo subito come questo possa ben definire la pratica psicoanalitica. Il signor X è un qualsiasi cittadino italiano che se ne va in giro con tutte le stesse prerogative appartenenti a tutti gli altri cittadini come lui. Se però nel contesto C, che può essere quello della seduta, X è in posizione di psicoanalista, cioè vale come Y, allora in quel contesto la sua parola può avere un valore di interpretazione. Questo non avviene per una particolare autorità di cui lo psicoanalista sia investito, ma semplicemente la funzione di cui è investito lo porta a occupare il posto vuoto di qualsiasi struttura istituzionale facendo lavorare questo vuoto attraverso una parvenza. In questo, credo, possiamo riconoscere la peculiarità della posizione e dell’operazione analitica, al di qua di tutte le definizioni identitarie, e al di qua anche di tutte le possibili trasformazioni esterne del procedimento. Perché, occorre dirlo, non solo la connotazione della psicoanalisi non passa attraverso variazioni esteriori: numero di sedute, durata, poltrona e divano o vis à vis. Anche le operazioni concrete possono variare senza comprometterne il valore. Consideriamo la svolta che nella nostra pratica si è prodotta quando abbiamo cominciato a parlare di psicoanalisi applicata. Potremmo dire: è Lacan che ha cominciato a parlare di psicoanalisi applicata alla terapia, già nel 1964. Sì certo, è vero! Ma che conseguenza aveva avuto allora nella pratica concreta della psicoanalisi? Nel 1964, menzionando questa espressione Lacan si riferiva a una sezione dell’Ecole che sta fondando, una sezione di psicoanalisi applicata alla psicoterapia e alla clinica medica, in contrapposizione a quella che invece denomina psicoanalisi pura. Non è esattamente quello che intendiamo oggi per psicoanalisi applicata. In realtà la psicoanalisi applicata ha cominciato ad esistere, nel senso in cui la intendiamo noi, quando Miller, riprendendo la frase di Lacan nel suo corso Le lieu e le lien del 2000-2001, ha preso a dargli corpo modellandola sulle esigenze della clinica attuale. E quando quest’idea ha iniziato a prendere consistenza ha iniziato anche ad avere conseguenze e ad avere ricadute nella pratica. Così nel 2002 si è avviato, a Milano e a Roma, il Cecli, il Centro clinico dell’Istituto freudiano; a Parigi nel 2003 si è aperto il CPCT, Centre Psychanalytique de Consultation et Traitement, iniziativa che si è diffusa poi a macchia d’olio in altre città in Francia, poi in Belgio, in Spagna, in Argentina, in Brasile. La psicoanalisi applicata ha inciso anche sul procedimento, lo ha modificato, per esempio limitando il numero delle sedute, mettendo in moto dei cicli, trasformando il maneggiamento della traslazione. Con la psicoanalisi applicata abbiamo aperto la possibilità della psicoanalisi allo spazio delle istituzioni, rispetto alle quali precedentemente la psicoanalisi era sempre stata un po’ extraterritoriale. E il procedimento nelle istituzioni non è lo stesso che il procedimento in studio. Questa trasformazione però ha avuto un contraccolpo anche nel lavoro che facciamo in studio: anche tra divano e poltrona la nostra pratica si è modificata. Non potremmo più definirlo, come facevamo nel 1992: un invito a parlare nel modo dell’associazione libera al quale lo psicoanalista risponde nel modo dell’interpretazione. D’altra parte l’idea stessa di interpretazione è stata messa in discussione. Nel 1995 Serge Cottet ha parlato di declino dell’interpretazione, e Miller ha ripreso questa affermazione accentuandola: l’interpretazione non può essere in declino perché è morta, ha detto (5). È chiaro che le cose devono andare in questo senso nel momento in cui cominciamo a parlare di inconscio reale (6), di rapporto con il godimento (7), di incidenza pulsionale, tutti elementi estranei al senso e quindi all’interpretazione. In fondo vediamo che tutto un quadro di riferimenti concettuali relativamente alla clinica si è trasformato: non cerchiamo più il nome di Freud come garanzia, anche se resta ovviamente un riferimento fondamentale. Nel momento però in cui denominiamo lacaniana la nostra Scuola, è evidente che pensiamo la nostra pratica più lacaniana che freudiana, cioè più orientata nell’operare sul godimento che sulla decifrazione interpretativa. E vediamo allora che il procedimento, che nel 1992 poteva fare da filo rosso, si è completamente trasformato. Cosa specifica allora la nostra pratica della psicoanalisi? Proviamo a capirlo guardandoci dall’esterno, rivolgendoci ai nostri critici. C’è tutto un orientamento all’interno della galassia lacaniana che vede il Campo freudiano e le sue Scuole incentrate intorno alla tesi – che considerano ideologica – del “declino del Padre”. La considerano ideologica perché la attribuiscono al Lacan degli anni Trenta, quello di Les complexes familiaux (8) . È qui che Lacan si riferisce per la prima volta a un declino dell’imago paterna e a una contrazione della famiglia tradizionale nella dimensione più ridotta della famiglia coniugale. Secondo questi critici, il primo dei quali è Markos Zafiropoulos (9), avremmo in questo testo un Lacan durkheimiano. È Durkheim infatti a mettere in luce questo contrasto tra l’antica famiglia patriarcale e la moderna famiglia coniugale (10). Lacan si sarebbe poi allontanato da Durkheim negli anni Cinquanta, dopo l’incontro con Levi-Strauss, dando vita all’impostazione strutturalista. Da Levi-Strauss Lacan avrebbe rilevato l’idea di “significante fluttuante”, che Levi-Strauss, nella prefazione al libro di Marcel Mauss (11) indica come simbolo zero, facendone il perno, secondo Zafiropoulos, per la costruzione del significante del Nome-del-Padre, e distinguendo a partire da qui la funzione simbolica paterna della presenza del Padre. Su questo presupposto Zafiropoulos considera che sul declino del Nome-del-Padre si incentra tutta la nostra clinica, la tematica dei nuovi sintomi con tutto quel che ne consegue come esercizio della psicoanalisi applicata. Poiché, secondo la sua lettura, la patologia contemporanea deriverebbe da un indebolimento della funzione simbolica del Padre, il rimedio non potrebbe essere che il suo rafforzamento, e il conseguente ripristino di questa funzione. Questa lettura presenta un’evidente distorsione della nostra clinica, giacché nella nostra pratica non abbiamo affatto preso come obiettivo la restaurazione del Nome-del-Padre, piuttosto il contrario. È interessante però capire la logica da cui deriva questa mistificazione. Il punto chiave è proprio nell’interpretazione che Zafiropoulos fa del simbolo zero come Nome-del-Padre. È vero che Lacan, in Funzione e campo, menziona questo simbolo zero (12) dopo un paragrafo in cui introduce il Nome-del-Padre, e il Nome-del-Padre è, fino al Seminario V, una sorta di significante supplementare, metalinguistico, che ha la funzione di coordinare l’insieme dell’Altro. Subito dopo però, nel Seminario VI, Lacan asserisce che non c’è Altro dell’Altro, ovvero non c’è il significante che sutura il sistema simbolico. Nel testo a cui Lacan fa riferimento, Levi-Strauss interpreta il mana – il termine melanesiano che indica in genere una forza vitale di origine soprannaturale – come un significante fluttuante, come indice di quel che considera una sovrabbondanza di significanti rispetto ai significati. Lo considera quindi equivalente a quelle parole tuttofare in francese come truc, machine, quel che noi in italiano diremmo un aggeggio, un affare, una roba. In ultima istanza sono termini che esprimono quel qualcosa indefinibile che se nel mondo polinesiano è indicato con il termine mana, è tuttavia assolutamente equivalente a un termine dell’antico scozzese che nel mondo occidentale abbiamo adottato: il glamour. Come il mana, anche il glamour appartiene al campo semantico della magia, ed l’incantesimo che fa apparire una persona più bella, più alta, più forte. In italiano è il fascino, è quel certo non so che, qualcosa di indefinibile che una persona possiede e che lo rende attraente. Il termine fascino viene poi dal latino fascinum, che indica generalmente un amuleto contro il malocchio, o un incantesimo per stregare qualcosa o qualcuno. Si tratta per lo più di un amuleto fallico. Priapo viene infatti anche denominato Fascinus. In tutte le forme in cui viene espresso si tratta di qualcosa che eccede le classificazioni del simbolico, o che non vi è compreso. In fondo quindi Lacan e Levi-Strauss affrontano il problema del simbolico in modo analogo: partono dall’idea di una mancanza d’armonia tra significante e significato, ma prendono poi due cammini diversi (13). Per Levi-Strauss la disarmonia tra significante e significato si manifesta in una sovrabbondanza di significanti che non si riescono a collocare in un significato. Dal suo punto di vista l’eccedenza sta dalla parte del significante. Le cose si possono vedere però anche dall’altro verso, nel senso cioè in cui la disarmonia consiste in una scarsità di significanti rispetto a quel che c’è da significare. Da qui vediamo che se Levi-Strauss fa del significante supplementare una sorta di punto di capitone che stabilisce il rapporto tra significante e significato, ne compensa la sperequazione, per Lacan questo simbolo zero è piuttosto qualcosa che diventa indice della mancanza nell’Altro, quel che sigla S (A̷). Nel linguaggio degli anni Cinquanta Lacan parla di mancanza e la mancanza è qualcosa che trova alla fin fine un suo posto nell’ordine. In base a questo definisce la fine dell’analisi, l’accettazione della castrazione considerata come una mancanza che niente può colmare. Nell’ultimo Lacan però la prospettiva cambia, si parla piuttosto di buco, e il buco non ha posto in nessun ordine, è una sorta di risucchio nel sistema, una potenza di destabilizzazione, ciò che mantiene un differenziale, e questo spostamento dalla mancanza al buco mostra anche come la pulsione ha ritrovato una sua funzione nell’ultimo insegnamento di Lacan. In ultima istanza vediamo dunque che Levi-Strauss va nel senso di ancorare, fissare, equilibrare, regolare il sistema simbolico. Da qui la concezione che si fa della malattia mentale riconducendola completamente a una condizione definibile come sociogenetica. Si tratta, secondo lui, di subordinare il fatto psicologico al fatto sociologico. Considera così che le condotte psicopatologiche individuali consistono nella formazione di un simbolismo indebolito, diverso da quello sociale. È chiaro che in questa prospettiva il trattamento delle problematiche mentali può consistere solo nel ricondurre le deviazioni mentali al mainstream del simbolismo collettivo. In questo senso, prendendo questa prospettiva, è chiaro che il Nome-del-Padre diventa ciò di cui si devono ristabilire le prerogative per condurre il soggetto deviante alla guarigione. In questo si manifesta quel che è il limite di fondo delle concezioni socio-genetiche della malattia mentale: la prospettiva che offrono è quella dell’adattamento. Questo vale anche se prendiamo le cose nel verso opposto rispetto a quello di Levi-Strauss, come nel caso di Basaglia. Nella storia della psichiatria italiana, e non solo, Basaglia ha svolto un ruolo fondamentale. Proprio partendo da una concezione sociogenetica della malattia mentale, ha fatto sua e realizzato una spinta riformatrice che ha trasformato la situazione dell’assistenza psichiatrica in Italia. Basaglia giunse infatti alla conclusione che non è il malato a dover essere aggiustato, ma la società, e che la malattia mentale sarebbe sparita in una società giusta. È una prospettiva più interessante di quella di Levi-Strauss, ma parte comunque del presupposto di una totale suturazione tra soggetto e società. Il punto di mira in ultima istanza della teoria sociogenetica è l’adattamento, sia nella versione conservatrice di Levi-Strauss, dove si tratta di accordare il soggetto ai significanti dominanti del simbolismo sociale, cioè a ciò che funge da Nome-del-Padre, sia nella versione rivoluzionaria di Basaglia, dove si tratterà di accordarsi a quello che sarà, quando avverrà, il simbolismo della società giusta. Lacan si mette in una prospettiva completamente diversa: parte dal punto di scardinamento tra significante e significato. Se a ogni significante corrispondesse un significato avremmo una batteria di significanti completa in un sistema simbolico coerente. Non è questo il caso. Per questo possiamo dire che le cose, in fondo, non sono mai a posto. Freud non opponeva una nevrosi a una normalità, poiché non poneva la psicoanalisi nella prospettiva di un recupero adattativo del nevrotico. La terapia di adattamento è la terapia considerata nella prospettiva levi-straussiana, dove tutto viene ricomposto, e dove in effetti il Nome-del-Padre deve funzionare da stabilizzatore. Nella prospettiva di Lacan non c’è invece un punto di mira normalizzante, una buona identificazione che indica il proprio posto nella relazione sessuale. C’è una falla nel sistema simbolico e si cerca di tamponarla con il sintomo. Per questo la psicoanalisi non è una terapia soppressiva del sintomo: analogamente al delirio nella psicosi, il sintomo è infatti un tentativo di soluzione, non un problema da superare. Si tratta poi di fare in modo che, diversamente da quanto accade nella nevrosi, il sintomo sia una soluzione non antieconomica, motivo per cui nella nostra visuale la psicoanalisi è un’esperienza mirata a utilizzare il sintomo, non a eliminarlo. Il sintomo è anch’esso un modo di nominare quel che eccede le possibilità del sistema simbolico. Quel simbolo zero con cui Levi-Strauss vuole algebrizzare l’idea che Marcel Mauss ci trasmette del mana, per Lacan resta una falla aperta nel sistema, e se il mana è un qualcosa tuttofare, è perché non è un significante: è buono per tutto perché non è identificato da nessun significante, resta un potenziale aperto nel sistema. Avendolo avvicinato al glamour, possiamo già capire dove mira questo accostamento, e vedere in cosa possiamo trovarlo nella terminologia di Lacan, poiché riguarda piuttosto ciò che è di per sé opposto alla struttura significante, ciò che costituisce l’elemento eterogeneo rispetto al significante, quel che Lacan chiama oggetto a. Presentare l’oggetto a nel punto di frattura tra significante e significato individua anche la posizione della psicoanalista, che consiste nell’occupare il posto del vuoto che nessun significante può colmare. Né il mana né il glamour sono riducibili a significante. Del glamour mi sono particolarmente interessato nel mio libro Il glamour della psicoanalisi (13) che, contrariamente a quanto hanno pensato alcuni giornalisti, non è un libro sulla moda. Riprendevo infatti in questo testo l’antica idea scozzese del glamour che, come ho già spiegato sopra, significava una sorta di incantesimo che rende attraente chi ne è investito. È chiaro che il glamour preso in questo senso indica un sovrappiù non identificabile ben riconoscibile nell’effetto della traslazione. Questo sovrappiù è talmente poco controllabile dal significante che, agli albori della psicoanalisi, esplodeva nelle più travolgenti e drammatiche storie d’amore: quella di Josef Breuer con Anna O., quella di Carl Gustav Jung con Sabrina Spielrein, quella di Viktor Tausk con Hilde Loewi. Per questo, a mio parere, nell’analisi di controllo, molto più che le operazioni che la psicoanalisi compie, è importante verificare la tenuta della posizione analitica. Proprio perché è una posizione impossibile, e lo è perché non è denotata da nessun significante, può a volte scivolare verso il discorso del padrone, impugnando un S1 da cui governare la situazione, o può slittare sul piano immaginario, producendo effetto di aggressività o di erotizzazione che bloccano lo sviluppo del lavoro analitico. È questo uno dei motivi per cui oggi, ma in fondo sempre, possiamo dire con sguardo retrospettivo che non è tanto nel procedimento che riconosciamo la specificità della psicoanalisi. Naturalmente ci possono essere operazioni più raccomandabili e altre meno, ma quel che fa il carattere più proprio della psicoanalisi è situarsi nel punto in cui si ha a che fare con quel “non so che” irriconducibile alle procedure. Anche quando parliamo di psicoanalisi applicata e del lavoro che facciamo nelle istituzioni, è chiaro che sarebbe difficile attenersi alla modalità classica formalizzata del rapporto tra una parola in associazione libera e una parola in modalità interpretativa. Ma per l’appunto non è questo l’essenziale. In un’istituzione la differenza tra noi e un cognitivista sicuramente salta agli occhi nel tipo di operazioni che realizziamo, ma più significativo è il fatto qualsiasi procedura decostruttiva del sintomo, come quella che ha di mira per esempio l’orientamento cognitivista, deve far ricorso a un Nome-del-Padre qualunque sia, foss’anche quello della scienza presa come supposto garante di una certezza che non risiede da nessuna parte. Nella psicoterapie che mimano le procedure e la metodologia della scienza, quest’ultima assume un ruolo di pura parvenza, una parvenza presa sul serio, una parvenza a cui si crede fermamente. Per noi l’utilizzo della parvenza è disgiunto dalla credenza, anche se far cadere la credenza nella parvenze richiede per esse tuttavia un certo rispetto, come sottolinea Miller in un intervento del 1997. Le parvenze servono – dice Miller – per “sistemare il mondo dell’inestricabile, sempre relativo, sempre precario”(15). Direi che questo mette in luce con la massima chiarezza la differenza tra un uso fisso, incantato, imbalsamato della parvenza, e un uso disincantato, leggero, lucido, agile. La disgiunzione tra significante e significato implica che sia possibile sapere in cosa e come ci sitiamo muovendo soltanto se si passa attraverso la parvenza. Mentre però la parvenza del Nome-del-Padre ha un valore normativo, noi sappiamo di trovarci in una molteplicità diversificata di giochi linguistici, alla Wittgenstein. Non siamo più nell’epoca di Frege e di Russell, quando si cercava un solido fondamento della logica per potersi muovere, siamo nell’epoca del reale senza legge, che è quella delle pratiche molteplici, delle diverse e varie forme di vita, nessuna delle quali ha un solido e immutabile fondamento ma, come diceva Nietzsche, ciascuna è come le pietre sulle quali poggiamo i piedi per traversare un ruscello: nessuna è stabile in modo definitivo: ci basta che faccia da punto di appoggio nel momento in cui ci permette di passare.
0 Comments
Leave a Reply. |
Marco Focchi riceve in
viale Gran Sasso 28 20131 Milano. Tel. 022665651. Possibilità di colloqui in inglese, francese, spagnolo Archivi
Giugno 2024
Categorie |
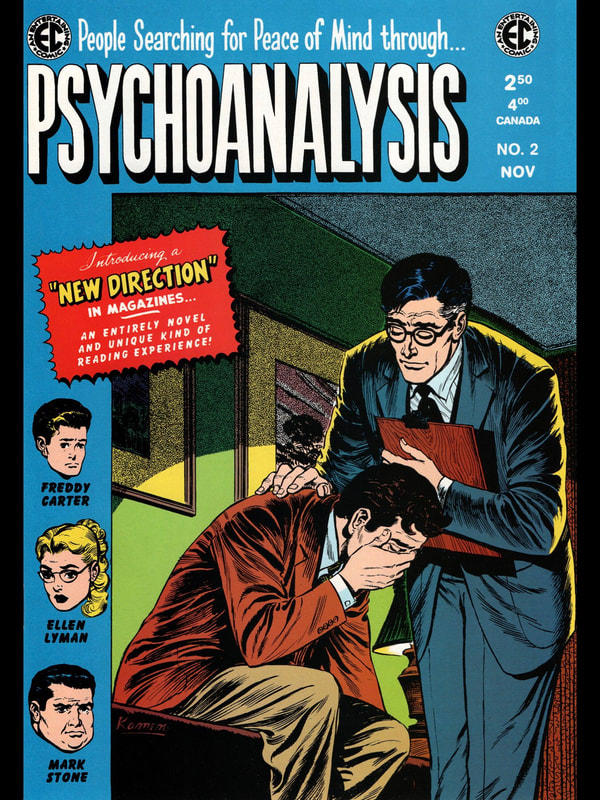
 Feed RSS
Feed RSS
